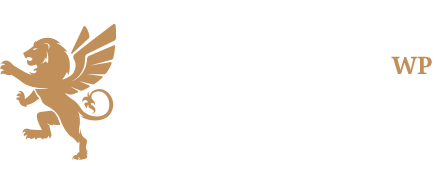FAQ
L’abbaiare del cane, è un suo diritto, o un disturbo per i terzi?

Va premesso che un cane che abbaia lungamente ha, molto probabilmente, qualche difficoltà e sarebbe bene interloquire con il proprietario per capire in quale situazione l’animale si trovi o venga gestito. In caso di resistenza ad ogni interlocuzione, si può sempre inoltrare la segnalazione alla Polizia Locale. L'abbaiare del cane rientra tra gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti, pertanto, come noto, un rumore di intensità e frequenza ``tollerabili``, è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Ciò vale per quanto concerne il ``disturbo alla quiete pubblica``, ovverosia ad una pluralità di soggetti (è sufficiente una lamentela di più persone sullo stesso fatto rumoroso per provare la sussistenza dello stesso). Se, invece, è un solo condomino o un vicino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica ed il cane ``può disturbare il vicino di casa`` che dovrà autonomamente provare il superamento della normale tollerabilità ed, in un eventuale procedimento giudiziale, dovrà essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dall'istante) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico. Se, ancora, il problema fosse l'abbaio notturno, allora anche una persona singola fornendo prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa dimostrando la continuità dell'abbaiare ed oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino, oppure, facendo rilevare con strumentazioni apposite ``quanto`` sia lesivo l'abbaiare dei cani) potrà agire per la cessazione della molestia ed il risarcimento del danno. Dunque, se la giurisprudenza ormai ha stabilito, inequivocabilmente, che abbaiare è un ``diritto esistenziale`` dei cani, è altrettanto vero che sussiste la responsabilità dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato e sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblica.
Cosa bisogna sapere prima di partire o andare in vacanza con un animale?

Prima di partire Assicurarsi che il proprio animale per il quale viga l’obbligo del microchip, lo abbia correttamente installato e funzionante. Per tutti gli animali, portare sempre con sé i documenti identificativi nonché il libretto sanitario. Se ci si reca in Paesi ove siano previste particolari vaccinazioni con termine di quarantena, attivarsi tempestivamente per svolgere tutte le incombenze. Verificare se il Paese di destinazione abbia regole restrittive o altre norme alle quali attenersi se si porta con sé un animale. Assicurarsi che il luogo dove si soggiornerà accetti animali e se vi siano limiti o particolari regole a cui attenersi. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico In Italia. E’ obbligatorio condurre il cane con guinzaglio (non estensibile) avente lunghezza non superiore al metro e mezzo, museruola alla mano, sacchetto per raccogliere le deiezioni (utile anche uno spray ecologico igienizzante per eliminare i cattivi odori). All’estero verificare se il Paese di destinazione abbia regole restrittive o altre norme alle quali attenersi se si porta con sé un animale. In viaggio In auto: si possono trasportare in auto soltanto animali domestici, in apposito contenitore omologato oppure nel vano posteriore dell'auto diviso da una rete o divisorio (se permanente, il dispositivo deve essere autorizzato dalla direzione generale della Motorizzazione Civile). E’ possibile viaggiare senza gabbia o nel vano posteriore diviso dalla rete ma con un solo animale domestico, assicurandosi che non sia di intralcio alla guida. In aereo, nave, treno: verificare sempre le condizioni di trasporto del vettore che possono variare anche in relazione alle dimensioni del trasportino richiesto.In spiaggia, parchi, montagna I divieti di accesso per gli animali nelle spiagge e nei parchi, devono essere disposti o da un’ordinanza del Sindaco oppure dalla Capitaneria di Porto, visibili e debitamente motivati (non può vigere un divieto assoluto su tutto il territorio comunale: deve essere sempre garantito al proprietario di un animale, cittadino contribuente, di fruire di aree apposite, ad esempio, nelle località balneari ci sono le Bau Beach e nei parchi le aree di sgambamento). Sui sentieri in montagna, bisogna verificare se vi siano regole stabilite, oltre che dal Comune di riferimento, anche dalle Riserve o dai Parchi ove ci si reca. Al ristorante Ad eccezione del divieto di accesso nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti, gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello. In pratica, in presenza di concrete e inderogabili esigenze di tutela igienico-sanitaria certificate dalle autorità sanitarie, l’esercente può richiedere il divieto di accesso a cani, gatti e altri animali d’affezione. E’ sempre utile, però, verificare se il Sindaco del luogo di vacanza abbia adottato un regolamento che favorisca l’accesso di cani e gatti alle strutture pubbliche (uffici pubblici, ristoranti, mezzi di trasporto, in alcuni casi anche ospedali e strutture sanitarie). Ritrovamento animale abbandonato o ferito o maltrattato Se possibile e senza che ciò comporti rischio per l’incolumità delle persone e dell’animale, mettere in sicurezza i luoghi (triangolo, avvisi direzionali, ecc.) e avvisare subito la Polizia Locale che interverrà attraverso la Asl veterinaria. Solo in caso non possa intervenire o non sia possibile contattarla, allora si potrà (con molta cautela, utilizzando un asciugamano/coperta) prelevare l’animale ferito o abbandonato e condurlo all’ambulatorio veterinario più vicino avvisando immediatamente l’autorità locale. In caso di investimento di un animale ed il conducente del veicolo procedesse la marcia senza arrestarsi a prestare soccorso, bisogna fermarsi subito e contattare l’Autorità di Polizia chiedendo l’intervento del veterinario e fornendo il numero di targa del fuggiasco (l’omissione di soccorso anche per gli animali è sanzionabile), luogo ed orario dell’incidente. Per gli animali selvatici è sempre bene contattare immediatamente i Carabinieri Forestali o il Cras (centro recupero fauna selvatica) più vicino.
DIRITTO PENALE - Come può tutelarsi la persona che riceve frasi minacciose o di morte?

Non tutte le frasi poco concilianti si traducono in minacce che si sostanziano in reato. Infatti, la minaccia deve rappresentare un pericolo concreto per chi la riceve, che si verifica ogni volta che qualcuno prospetta ad altri un danno tale da poter essere considerato ingiusto. Bisogna, dunque, esaminare, caso per caso, sia elementi oggettivi del reato di minaccia, sia il livello di gravità, nonché l’effetto della minaccia stessa su chi la subisce (ad esempio limitandone la liberà psicofisica). Infatti, la stessa frase minacciosa può assumerne un diverso profilo in base allo stato della persona che le pronuncia, al contesto in cui viene pronunciata e agli effetti che producono sul destinatario della minaccia. Normalmente le minacce sono espresse verbalmente in modo diretto ma, sempre più spesso, anche indirettamente, tramite messaggistica istantanea, email, gesti (ad esempio, puntare una finta arma), ecc... Nel momento in cui si riceve una minaccia, soprattutto se le circostanze ne palesano la gravità e il pericolo che ne discende (ad esempio, minacce di morte), bisognerà sporgere querela scritta o orale, recandosi presso il Comando dei Carabinieri o un Commissariato di P.S. o ad un qualunque ufficio di Polizia Locale; mentre, se ci si rivolge direttamente alla Procura della Repubblica, la querela deve presentarsi per iscritto. Ciò vale anche nel caso in cui colui che riceve la minaccia non era presente nel momento in cui la minaccia è stata espressa ma ne è stato informato da terzi. La querela deve essere presentata da chi ha ricevuto la minaccia entro tre mesi dal fatto e, nei casi di minaccia aggravata, è procedibile d’ufficio. E’ importante distinguere il reato di minaccia (art. 610 Codice Penale) da quello di violenza privata (art. 612 Codice Penale), poiché hanno profili oggettivi, spesso, simili. Quindi, è fondamentale verificare l'elemento intenzionale: per la sussistenza della minaccia è sufficiente che l'agente eserciti genericamente un'azione intimidatoria; per la violenza privata, invece, occorre un ulteriore elemento che è quello del costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi altrui volontà estrinsecata in un comportamento forzato.
DIRITTO PENALE - Come può tutelarsi la persona che subisce atti persecutori-stalking?

Quando il reiterato comportamento di un soggetto ingenera, nella persona che lo subisce, uno stato di disagio psicologico, una situazione emotivamente alterata, ua modifica delle proprie abitudini e del proprio modo di vivere, o, più in generale, un sentore di oppressione ed ossessione cagionate da tale condotta, si integra il reato di atti persecutori cosiddetto stalking (art. 612 bis Codice Penale). Tale comportamento può, ad esempio, sostanziarsi con l’invio compulsivo alla vittima di messaggi o e-mail; di continue telefonate; appostamenti sotto casa o presso il luogo di lavoro; nell’utilizzo molesto di mezzi ulteriori anche informatici, come, ad esempio, la pubblicazione di “post” sgradevoli sui social network di cui la vittima sia destinataria, fino a seguire la persona offesa in luoghi pubblici, spiarla, o peggio, al ripetuto tentativo di contatto fisico o di qualsivoglia altro tipo con la vittima. L’atto persecutorio, quindi, non è solamente quello legato alla qualifica della persona offesa che sia partner o ex partner dell’agente, ma anche quello individuato come “stalking familiare“ (ove l’agente estrinseca il suo comportamento nell’ambito del nucleo familiare), oppure, lo “stalking condominiale” (si sostanzia a danno di un condomino da parte di un altro) o, ancora, lo “stalking occupazionale” (si configura sul luogo di lavoro a danno di un collega o di un subordinato) e, infine, il nuovo “cyberstalking“ (ove il mezzo utilizzato a danno della persona offesa è un mezzo informatico). La vittima di atti persecutori, per tutelarsi, può proporre querela, entro il termine di sei mesi decorrente dalla data dell’ultimo atto persecutorio subito. E’ procedibile d’ufficio, invece, se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità oppure se il fatto è commesso da un soggetto già attinto dall’ammonimento questorile. Per quanto riguarda l’ammonimento del Questore, la vittima di atti persecutori può rivolgersi , appunto, al Questore, affinché l’autore del comportamento persecutorio venga raggiunto da un avviso orale di desistere dalla condotta molestante: il cd. ammonimento. In questo caso, la persona offesa deve rivolgersi al Comando dei Carabinieri, ad un Commissariato di P.S. o ad un qualunque ufficio di Polizia locale (che provvedono poi ad inoltrare l’istanza al Questore territorialmente competente). L’inosservanza del provvedimento di ammonimento del Questore comporta la procedibilità di ufficio del reato di stalking.
DIRITTO DI FAMIGLIA E RAPPORTI DI CONVIVENZA - Cosa può fare il titolare dell’assegno di mantenimento in caso di mancata corresponsione da parte dell’obbligato e quando, invece, cessa l’obbligo di corresponsione?

In caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per i figli o il coniuge, si possono esperire diverse azioni a tutela del beneficiario, sia in sede civile, sia penale. In ambito civilistico, si può giungere ad ottenere un provvedimento del giudice che consenta il pignoramento dei beni del debitore (conto corrente e altri beni). In questo caso, è necessario inviare una diffida all’obbligato e, se non provvede, occorre procedere – a seconda dei casi – al decreto ingiuntivo o al precetto – e, poi, al pignoramento. Laddove dovesse sussistere il concreto pericolo che il debitore per il mancato versamento del mantenimento possa sottrarsi ulteriormente al proprio adempimento, o dilapidare il proprio patrimonio, la legge prevede che il giudice disponga del sequestro conservativo dei beni pignorabili. Tali beni saranno totalmente volti al soddisfacimento dei bisogni che la prole manifesta. Per agire in sede penale deve valutarsi un ulteriore aspetto, cioè se sussista il dolo del debitore , cioè la libera volontà di sottrarsi al pagamento dell’assegno di mantenimento, pur avendo di fatto tutte le facoltà ed i requisiti economici per poter provvedere a tal scopo. Viene escluso, dunque, il profilo penale nel caso in cui il debitore non si trovi nelle condizioni di potere assolvere l’obbligo di mantenimento perché conseguenza inevitabile della reale precaria condizione economica in cui versa, come il peggioramento delle condizioni economiche. Il beneficiario del diritto alla percezione dell’assegno di mantenimento lo perde qualora il giudice della separazione pronunci l’addebito della separazione a suo carico (oltre alla perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge). Mentre, il coniuge a cui viene addebitata la separazione, invece, conserva l’obbligo di mantenere l’altro coniuge e i figli, e, ove ne ricorrano i presupposti, ha diritto al versamento degli alimenti. Altra causa della perdita del diritto alla percezione dell’assegni di mantenimento si verifica quando il beneficiario presenta mezzi adeguati o la possibilità di procurarseli, con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica (desunta da quattro indici: possesso di redditi; di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro; stabile disponibilità di una casa di abitazione). Se il beneficiario passa a nuove nozze o costituisce una convivenza di fatto che abbia i caratteri della stabilità, della continuità e della regolarità, il medesimo perde il diritto all’assegno di mantenimento e di quello divorzile. Anche, la morte di colui che è obbligato a versare l’assegno di mantenimento, estingue tale l’obbligo. Però, l’avente diritto può ottenere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con l’assegno periodico. Anche il coniuge divorziato, pur perdendo i diritti successori, può avere diritto a percepire un assegno successorio a carico dell’eredità (tenuto conto dell’importo dell’assegno di divorzio. In entrambi i casi, il valore dell’assegno è dato in base al quantum ricevuto sino al momento della morte, all’entità del bisogno, alla consistenza dell’eredità e al numero e delle condizioni economiche degli eredi, all’entità del bisogno, all’eventuale pensione di reversibilità ealle sostanze ereditarie e salvo che il coniuge non abbia ricevuto la corresponsione in unica soluzione.
DIRITTO DI FAMIGLIA E RAPPORTI DI CONVIVENZA - A chi viene affidato il cane o il gatto in caso di separazione o di cessazione della convivenza di fatto?

L’animale va considerato “essere senziente”, secondo la definizione del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 13 dicembre 2007. Nel trattato, che tutela gli animali dai maltrattamenti, si sottolinea che “nel formulare e incrementare le politiche sull'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, l’Unione e gli Stati membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali stessi”. “Essere senziente” significa essere dotato della capacità di sensazione e non essere considerato una cosa di proprietà di qualcuno. Su tale assunto, la Corte di Cassazione, con decreto 13 marzo 2013 ha stabilito che: “il gatto, come anche il cane, deve essere considerato come membro della famiglia e per tali motivi va collocato presso il coniuge separato con regolamento di spese analogo a quello del figlio minore”. Dunque, proprio perché ormai l'animale domestico è considerato elemento strutturale della famiglia, il giudice può prendere in considerazione il problema dell’affidamento del cane o del gatto o di altri animali domestici, nel momento in cui ci sono dei bambini minori particolarmente legati. Difatti, il codice civile stabilisce che il principale scopo che deve perseguire il giudice, nel momento in cui stabilisce le condizioni di separazione e divorzio dei coniugi, è la tutela dell’interesse morale e materiale del minore. Ciò quindi non è di ostacolo ad un provvedimento che disciplini anche la sorte degli animali domestici. Se non vi sono minori, ai fini della decisione sull’affidamento degli animali domestici, si potrà valutare l’intensità del rapporto con uno dei separandi (in questo caso con i soggetti sottoposti a esecuzione forzata). In linea di massima i Tribunali, in assenza di una norma di riferimento, applicano la disciplina prevista per i figli minori, disponendo l’affido condiviso del cane con obbligo di suddivisione al 50% delle spese per il suo mantenimento. Ciò, in quanto, l’animale crea un rapporto significativo con entrambi i coniugi/conviventi che va salvaguardato.
DIRITTO CIVILE - Il creatore di un’opera (libro, film, brano, musicale software e altre opere di arti figurative) che ha concesso in licenza i diritti sull’utilizzo di quest’opera a un altro soggetto, cosa può fare se i termini economici o di utilizzo della licenza non vengono rispettati o se l’opera viene utilizzata senza consenso dell’autore?

La tutela del diritto d’autore, regolata dal Codice Civile e dalla Legge 633/1941, è finalizzata a proteggere gli interessi morali e materiali connessi alla creazione di opere dell’ingegno, letterarie, scientifiche ed artistiche. Nel casi in cui il titolare del diritto d’autore teme la violazione del suo diritto di utilizzazione economica, oppure, vuole evitare la ripetizione di una violazione già avvenuta, può, attraverso un’azione di accertamento, ottenere una dichiarazione giudiziale che attesti la titolarità del diritto d’autore in capo all’autore stesso. Se richiesto, giudice può anche, attraverso un’azione inibitoria, fissare una somma dovuta al titolare del diritto d’autore per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nella cessazione della violazione. Il titolare del diritto può ottenere, altresì, il risarcimento per i danni subiti a causa della violazione del diritto d’autore, che possono essere danni materiali (ad esempio, la perdita di guadagni derivanti dalla commercializzazione non autorizzata dell’opera) e danni morali (il pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore). Solitamente, contestuale alla richiesta di risarcimento del danno, può chiedersi al giudice di ordinare la distruzione o la rimozione dello stato di fatto da cui deriva la violazione (molto frequente nel contesto digitale, dove le piattaforme online ospitano materiale che viola il diritto di cui sono titolari).
DIRITTO CIVILE - Cosa può fare il condomino che subisce infiltrazioni d’acqua provenienti dal soffitto del proprio immobile se l’amministratore non si attiva per la riparazione?

E’, innanzitutto, essenziale accertare la causa delle infiltrazioni, sia per porre rimedio alle stesse, sia per individuare il soggetto tenuto a sopportare i costi delle riparazioni e del risarcimento dei danni. A tal fine, il condominio danneggiato deve immediatamente avvertire, per iscritto, il proprietario dell’appartamento dal quale si presume provengano le infiltrazioni, sia l’amministratore di condominio, per concordare un sopralluogo (utile è la presenza di un tecnico superpartes o i rispettivi tecnici di parte) e gli interventi da eseguire. Se viene accertato che le infiltrazioni sono riconducibili a carenze, difetti o rotture di tubature condominiali o di altre parti comuni dell'edificio, l'amministratore deve attivarsi, tempestivamente, per la riparazione del danno. Trattandosi di lavori urgenti (rischi di distacco dell'intonaco o di calcinacci con pericolo per persone e cose; muffe e batteri che rendono gli ambienti insalubri, pregiudizievoli e lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo) non è necessario convocare l’assemblea straordinaria. Se, però, l’amministratore non si attiva, il condomino può inviare, tramite un legale, una diffida e, sempre in ambito stragiudiziale, tentare l'esperimento di un procedimento di mediazione innanzi ad apposito organismo ADR, in seno al quale potrebbe anche disporsi una perizia super partes per stabilire le rispettive responsabilità e gli interventi da eseguire. Se nemmeno in ambito stragiudiziale si giunge a al risultato auspicato, oppure la situazione è talmente grave da indurre a scegliere la via più urgente, il condomino, assistito da un avvocato, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria richiedendo l'adozione di un provvedimento urgente, detto “cautelare”, che condanni, rapidamente, l'amministratore di condominio ad effettuare i dovuti lavori di riparazione. E' evidente come sia necessario agire con la massima sollecitudine onde evitare l'aggravamento dei danni che, peraltro, potrebbero farsi ricadere sul condomino negligente. Infatti, il condomino può chiedere il risarcimento dei danni causati al proprio appartamento ed ai propri beni e il rimborso di quanto speso per l'affitto temporaneo di altro appartamento (il tutto dovrà essere opportunamente documentato).
DIRITTO AGRARIO - Come esercita il diritto alla prelazione agraria l’affittuario coltivatore diretto e il proprietario confinante? L’istituto si applica anche nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico o di costruzione di un parco agrivoltaico?

La prelazione dell’affittuario coltivatore diretto è disciplinata dall’art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre, quella del proprietario confinante dall’art. 7, comma 2, della Legge 14 agosto 1971, n. 817. Tale istituto si applica anche nel caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico o di costruzione di un parco agrivoltaico, in quanto, non muta la destinazione agricola del fondo e il rilascio dell’autorizzazione unica non comporta una variante allo strumento urbanistico. Per esercitare il diritto di prelazione agraria devono sussistere specifici requisiti: i terreni devono avere destinazione agricola e, qualora sia presente un fabbricato rurale, quest’ultimo deve rapporto di pertinenza rispetto al fondo; l’esercitante il diritto deve essere coltivatore direttamente e abituale del fondo da almeno due anni (per fondo si intende quello posto in vendita in caso di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto o quello confinante di prelazione del proprietario confinante) e non deve avere venduto altri fondi rustici nel biennio precedente; il terreno, unitamente agli altri posseduti in proprietà o in enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia dell’avente diritto di prelazione. Per l’esercizio del diritto di prelazione bisogna seguire un apposito iter procedurale: il proprietario che intende vendere il proprio fondo deve notificare tale sua intenzione – la proposta di vendita - all’avente diritto di prelazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Ufficiale Giudiziario. L’avente diritto ha trenta giorni, dalla avvenuta ricezione, per esercitare il diritto di prelazione decorrenti dall’avvenuta ricezione. Entro i successivi sei mesi (per l’affittuario coltivatore diretto) o tre mesi (per il caso del proprietario confinante), decorrenti dal trentesimo giorno dall’avvenuta notifica della proposta di vendita, l’avente diritto di prelazione è tenuto a pagare il prezzo di compravendita, pena la decadenza dal diritto di prelazione.
DIRITTO AGRARIO - Come è regolata la durata di un contratto di affitto di un fondo rustico?

La normativa disciplinante l’affitto di un fondo rustico è, per lo più, contenuta nella Legge n. 203 del 1982 la quale, nel Capo I del Titolo I (articoli 1-7), e riguarda, in particolare, la durata del contratto. La durata del contratto stipulato senza assistenza sindacale, tra il proprietario del fondo e un coltivatore diretto, ha una durata minima di 15 anni con rinnovo automatico alla scadenza di ulteriori quindici anni e così via, ad ogni successiva scadenza. La parte che non voglia proseguire nel rapporto contrattuale, può inviare una lettera di disdetta all’altra parte, a mezzo raccomandata a/r (o a mano o, se entrambi la hanno, tramite pec) che deve essere da quest’ultima ricevuta, almeno un anno prima del termine di scadenza, originario o prorogato, del contratto. Posto che il limite massimo di durata di un contratto è fissato in 30 anni, non è contemplato quello per la durata minima, però, questo limite minimo deve tenere conto del tempo necessario per consentire il compimento del ciclo biologico della coltura praticata sul fondo.
DIRITTO AMMINISTRATIVO - Il proprietario del bene espropriato per pubblica utilità può chiedere la restituzione del bene se la pubblica amministrazione non realizza l’opera nei termini previsti dalla legge?

Quando lo Stato deve perseguire un interesse pubblico e necessita di acquisire la proprietà privata di un bene nella sfera giuridica propria o di altri, si può avvalere dell’istituto che disciplina l'espropriazione per pubblica utilità. Tale sacrificio subito dal soggetto espropriato viene ricompensato con una indennità. Quando, però, l’opera pubblica non viene eseguita e siano decorsi i termini concessi o prorogati dalla legge, il proprietario espropriato può adire il giudice ordinario per chiedere la retrocessione. Se, invece, dopo l’esecuzione totale o parziale dell’opera, solo alcuni beni espropriati non hanno ricevuto la destinazione prevista dalla legge, sino a quando l’amministrazione non abbia dichiarato che quei beni non sono più destinati alla realizzazione dell’opera pubblica, il proprietario espropriato può ricorrere al giudice amministrativo. In ogni caso, la ricorrenza dell’una o dell’altra ipotesi è vagliata, sia riguardo al decreto di espropriazione sia (e soprattutto) alla dichiarazione di pubblica utilità.
DIRITTO AMMINISTRATIVO - Cosa può fare il candidato ad un concorso pubblico se ritiene di essere stato ingiustamente escluso o se ritiene errata l’attribuzione del proprio punteggio nella graduatoria?

L’Amministrazione può incorrere in irregolarità nella procedura di concorso, sia nella fase iniziale di predisposizione del bando, sia in quella dello svolgimento della prova, sia, infine, in quella di predisposizione della graduatoria. Nella stesura del bando di un concorso l’Amministrazione può commettere errori rendendolo irregolare. In questo caso il candidato può impugnare autonomamente il bando, in quanto immediatamente lesivo, innanzi al giudice amministrativo per ottenere un provvedimento che consenta l’ammissione al concorso. Se, invece, il partecipante al concorso ritiene che nella graduatoria finale gli sia stato attribuito un punteggio non rispondente ai titoli posseduti o che non tiene conto di situazioni personali che danno diritto a un punteggio ulteriore, può impugnare detta graduatoria, sia per ottenere un punteggio maggiore, sia per contestare il punteggio attribuito ad altri candidati posizionati aventi a lui in graduatoria. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare, che decorre dalla pubblicazione del bando, se è questo atto che si vuole impugnare; dallo svolgimento della prova, se si vogliono denunciare irregolarità rilevate nel corso dello svolgimento della stessa; dalla pubblicazione della graduatoria, se oggetto dell’impugnativa è quest’ultimo atto.